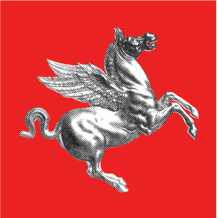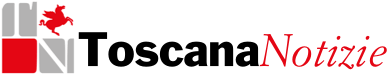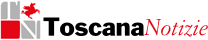La notte s'ingrossa. Il treno dei ragazzi toscani alle undici si ferma per una lunga sosta a Linz. non c'è più neve, quella che ha accompagnato il convoglio dal Brennero fino a Salisburgo. C'è ancora qualche ragazzo che fa la spola per scambiare una parola con Tatiana Bucci o per qualche domanda ad Ernesto e le ragazze rom e sinti. Poi pian piano il lento si assopisce e dai libri e dai ricordi escono dal buio storie che vorresti inventate, partorite dalla fantasia di un qualsiasi scrittore di horror, ed invece purtroppo accadute, anche se ancora oggi qualcuno le vorrebbe negare.
I libri servono per imparare e per comunicare, che diverso dal solo informare perch c' una comunione di emozioni. Li sfogli avidamente e scopri che nei lager non si arrivava solo con i carri piombati ma anche, ignari, in prima classe, convinti magari di raggiungere un paese neutrale. Senza scorta e con il personale ferroviario di ordinanza, tra fanciulle smagrite e curate nei vestiti e madri che accomodavano con amore la copertina ai neonati. Accadeva a Treblinka, sessanta chilometri da Varsavia, dove era stata costruita anche una finta stazione, con tanto di biglietteria e destinazioni in testa a binari in realtà morti. Crudeltà nella crudeltà. A Treblinka, fabbrica costruita solo per uccidere, ogni giorno finivano nelle camere a gas in almeno diecimila e pi di tre milioni sono morti in tredici mesi.
Quello che l succedeva ce lo racconta VasiliJ Grossman, uno scrittore in guerra, inviato d'eccesione e corrispondente dal fronte al seguito dell'Armata Rossa. Il suo libro, "L'ingerno di Treblinka", pubblicato la prima volta già nel 1944, un vero e proprio reportage, scritto di getto e con testimonianze di prima mano. Chi scrive ha il dovere di raccontare una verità tremenda, e chi legge ha il dovere civile di conoscerla, questa verità. Parole che sono la stella polare ancora oggi del vero giornalismo.
Ignari si arrivava anche nei ghetti, come a Cracovia, e dai ghetti si partiva, senza sapere di andare incontro alla morte "Il farmacista del ghetto di Cracovia" una lettura illuminante.
Altre storie ci parlano delle donne deportate, il cui destino, anche quando non venivano stuprate ed uccise dai loro carnefici il giorno dopo, era quasi sempre peggiore di quella degli uomini. La penna e il ricordo in questo caso di Liana Millu, pisana trapiantata a Genova, scrittrice e insegnante, antifascista e partigiana scomparsa nel 2005. Il suo libro, "Il fumo di Birkenau, del 1947, lo stesso anno di "Se questo un uomo" di Levi, tra i primi sette memoriali italiani scritti subito dopo la guerra, e ci racconta di sei donne, sue compagne di prigionia, prima a Birkenau e poi Ravensbruck, l'unico lager tutto al femminile della Germania nazista.
C'è Lilly, mandata a morte con un cenno indifferente della sua Kapo, che la temeva come rivale in amore. C' Maria, che entra nel lager senza denunciare la sua gravidanza, anzi la nasconde fasciandosi il ventre, perché vuole che il bambino nasca. E nasce infatti quel bambino, nella bolgia notturna di una baracca lurida, senza luce n acqua n un panno pulito, nella ridestata pietà delle compagne prigioniere. Ma all'appello la mattina nessuno può mancare e mamma e bambino si dissanguano e muoiono, prima che l'appello finisca.
Nelle sei storie c'è anche Bruna, che ritrova il figlio adolescente in un lager contiguo: si abbracciano attraverso il reticolato elettrico e rimangono fulminati. Il libro racconta della russa Zina, che si gioca la vita per favorire la fuga di Ivan, che non conosce ma che le ricorda vagamente il marito ucciso dai nazisti. E poi ci sono le due sorelle olandesi una sceglie la vita del bordello, l'altra la rinnega e la moglie innamorata e combattuta tra due destini: mantenersi fedele al marito e morire di fame oppure cedersi, per un giorno sperare magari di rivederlo. I migliori non sempre li trovavi tra i salvati, ricordava spesso Primo Levi. Sopravviveva nei campi solo chi meglio sapeva adattarsi.